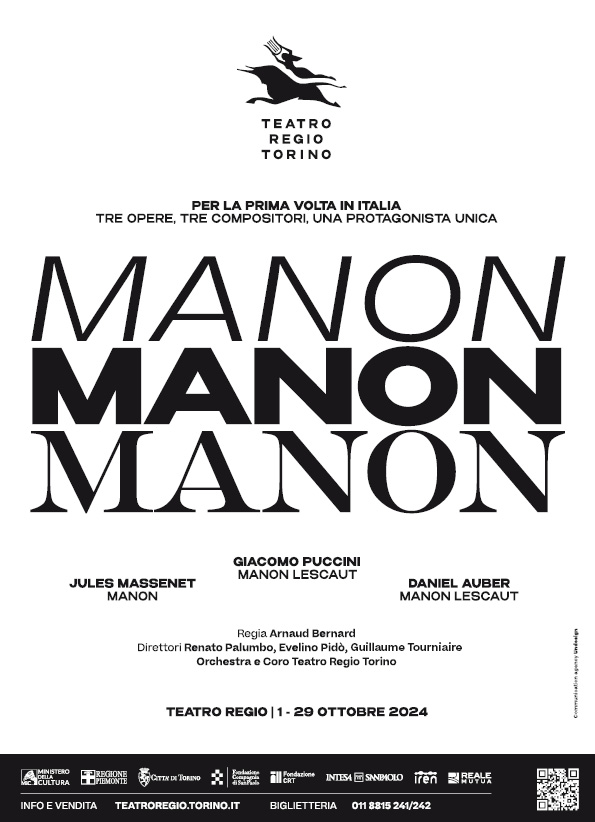Il grande soprano Jessye Norman è morta all’età di 74 anni.
È stata una delle ultime incantrici della scena lirica, dotata di una voce dal timbro carnale e dalle vibrazioni che provocavano nell’ascoltatore un torrente di emozioni. La sua voce, come poche, sa parlare dell’anima e va all’anima.
Il suo repertorio operistico, che spaziava dal barocco alla musica contemporanea, non fu vastissimo, ma in ogni sua interpretazione seppe lasciare il segno di una personalità e sensibilità ammalianti.
Fu una eccelsa liederista e negli ultimi anni di carriera si era distinta anche negli spirituals.
Intensa la sua attività discografica, sempre realizzata al fianco di grandissimi direttori con i quali ha collaborato nel corso di una memorabile carriera.
Qui di seguito un approfondito ritratto della sua arte, a cura di Giancarlo Landini.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
JESSYE NORMAN, APPUNTI PER UN RITRATTO
Una voce fuori dal comune
Scompare Jessye Norman. Scompaiono una voce e un’artista delle più grandi della seconda metà del XX secolo. Una delle più singolari, capace di costruirsi una carriera particolare, fuori dal comune. Nella mia parabola di ascoltatore ho incontrato, per la prima volta, Jessye Norman nelle recite scaligere di Aida nel 1972, diretta da Claudio Abbado. La Norman cantò nelle serate del 18, del 22 aprile e del 4 maggio. Subentrò a Martina Arroyo, che poi fu scritturata, con Josella Ligi, per gli spettacoli previsti in settembre, a Monaco di Baviera, in occasione di quelle Olimpiadi insanguinate dal terrorismo. Non fece impressione e il loggione non mancò, seppure senza eccessi, di rimproverarle una scarsa presenza vocale. Fresca di debutto, in quel contesto verdiano, la Norman sembrò un altro soprano di colore destinato a recitare la parte più o meno felice dell’epigono di Leontyne Price, come per certi versi fece l’Arroyo. Sfuggì, però, al loggione la bellezza di una voce di prima classe. Il lettore potrà sincerarsi della bontà dell’affermazione, ascoltando in rete i brani dell’Aida di Parigi del 1973. Voce bellissima, emessa con morbidezza. Il colore intenso dei centri si faceva ancora più scuro nel grave, dando alle note una timbratura assai suggestiva, un colore fosco, un alone notturno. Era una caratteristica così evidente che, nel Duetto con Amneris del II Atto, la voce della Norman poteva persino sembrare quella di un mezzosoprano. In realtà quando dal centro saliva verso la regione acuta, la voce, utilizzando un diverso registro, perfettamente innestato sul medium, si illuminava, creando un giusto e suggestivo contrasto. In alto, però, mostrava di essere corta o meglio di non possedere quello slancio che deve essere proprio del soprano sfogato e che la vocalità verdiana esige. Ma forse il loggione intuì quello che poi sarà una verità: non era quella la strada da seguire. La Norman doveva ancora trovare in sé stessa la vera Norman, che non poteva essere un soprano puro e che non poteva battere le strade di un canto tradizionale.
Un singolare soprano Falcon
Per chi ama classificare le voci e si chiedesse a quale categoria appartenesse quella di Jessye Norman, la risposta potrebbe essere semplice. Jessye Norman può essere definita un soprano Falcon, vale a dire quel tipo di chanteuse forte che accoglie nella sua voce la possibilità di accostarsi a ruoli dalla tessitura bifronte. Sarebbe abbastanza riduttivo definire il Falcon un soprano corto o un mezzosoprano acuto. Si tratta piuttosto di qualche cosa di diverso, di quasi sovrapponibile, ma non del tutto o non completamente a queste due tipologie. A suggerire questo accostamento concorre, manco a farlo apposta, il fatto che l’anno prima della citata Aida scaligera Jessye Norman aveva debuttato a Firenze nell’Africana, diretta da Riccardo Muti, cantando splendidamente Selika. La parte fu scritta da Marie Sasse, che potrebbe essere presa come esempio di soprano Falcon. Ma se la Norman fu un soprano di questo genere lo fu in maniera originale e personale.
La particolarità della sua carriera, tutto sommato breve – nel Novanta la parabola era decisamente discendente e nella seconda metà di quelli Ottanta i momenti migliori stavano passando – nasce anche dal fatto che la Norman preferì il concerto e la sala d’incisione ad una vita sulla scena così come la si intende. A questa scelta concorse il fisico, anche se questa spiegazione non mi ha mai convinto del tutto. Non mancano esempi recenti di artisti di fama planetaria che hanno calcato le scene tra il generale gradimento nonostante una corporatura non proprio teatrale. Mi sembra che la scelta le abbia permesso, invece, di accostarsi in maniera diversa ai ruoli e personaggi.
La Carmen discografica della Norman non è solo ben cantata, ma è interpretata, con il pieno avallo della bacchetta di Ozawa, dentro una dimensione che trae forza dalla sua anti-teatralità. Non credo che il non averla mai affrontata sulla scena tolga credibilità alla prova, come non ne tolse alla gitana della Price, che mai interpretò l’opera di Bizet sulla scena, ma ne realizzò con Herbert von Karajan una lettura spettacolare. Il disco, peraltro, non è solo la fotografia di una performance teatrale, ma (specie quando le case discografiche erano in grado di produrre in studio) rappresentava un’alternativa al palcoscenico, un modo di realizzare un’interpretazione in sé compiuta. Così come sono in sé compiuti i brani del Samson et Dalila che si ascoltano intonati dalla Norman o quelli della Damnation de Faust.
La Santuzza della Cavalleria rusticana, diretta da Bychkov per la Philips, è li ad attestarci che quella vocalità e quel canto calzano a pennello alla voce del soprano americano. Che – sia detto con chiarezza – dimostra anche di avere buona dizione e di aderire alla linea di canto di Mascagni. Ma a patto di capire che è una Santuzza del tutto particolare, lontano dalla consueta concitazione. Tutta questa Cavalleria rusticana è all’insegna di una lettura lirica, di una teatralità composta, dettata dal direttore, ma magnificamente sposata dalla Norman che concorre a conferire all’opera il passo di una tragedia greca, a farne la celebrazione di un mito di amore e di sangue. In questo contesto un passo come “priva dell’onor mio” offre non solo un esempio superbo di canto sul fiato a mezza voce, ma anche uno splendido esempio di interiorizzazione della frase intonata, senza che la puntatura su cui sfoga perda di forza, anche se di una forza riportata al dramma e sottratta al teatro. Chi cerca una più accentuata teatralità, l’emozione forte, può rimanere deluso. Si avverte qui che da un lato il soprano americano si accosta a questo teatro italiano con un certo riserbo, dall’altro che la dimensione a lei più congeniale sia quella aulica. Non è un caso che uno dei momenti più riusciti dell’incisione di questa Cavalleria rusticana sia il Duetto con Alfio e in specifico nel Largo, “Turiddu, mi tolse l’onore”. È pagina stupenda, una delle più pregnanti del capolavoro mascagnano, momento drammatico quant’altri mai, dove la tragedia sentimentale di Santuzza si fa spirituale e si esprime in un lamento antico. Non è un caso che questo passo, spesso dimenticato dalla critica e dal pubblico, abbia trovato piena espressioni in voci estranee alla tradizione – ah! la tradzione grande nemica della Musica! – come Maria Callas o, appunto Jessye Norman.
Le strade di Jessye Norman
Così nella carriera della Norman abbiamo un percorso classicista, le cui tappe vanno dal Dido and Aeneas, all’Hippolyte et Aricie di Rameau, all’Alceste di Gluck fino alla Cassandre de Les Troyens di Berlioz.
Purcell ha ben dipinto il dramma dell’infelice regina di Cartagine e nel lamento, “When I’m laid in earth”, ha rivissuto i versi famosi (“sic iuvat ire sub umbras/hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto/Dardanus, et nostrae secum ferat omina mortis”) del IV libro dell’Eneide di Virgilio in una dimensione patetica squisitamente barocca. Jessye Norman, a sua volta, ha dato voce a questo canto, che poggia su di un’orchestra disadorna e chiede di recitar-cantando, di dare corpo alle frasi che vivono di una declamazione melodica che ora si accede e si fa turgida e ora si ripiega, segnata dal fatale “remember me” che suona incisivo come una maledizione e che poi, invece, si fa eco dimessa e mesta. Tale commozione, nel senso latino del termine, trova espressione nel timbro, nei colori, nella perfezione del canto legato, nell’espressione sempre giusta delle sillabe e delle parole, nell’autorevolezza regale del porgere la frase e nel vivere il dolore del personaggio, che sono qualità proprie del soprano americano.
Chi ha frequentato il Festival di Aix-en Provence nei suoi anni migliori non potrà mai dimenticare l’effetto prodotto dall’opera di Rameau, in virtù di tre elementi che combinati tra loro attinsero alla perfezione: la direzione di Sir Eliot Gardiner, l’allestimento firmato da Pier Luigi Pizzi e la Phédre di Jessye Norman. Il direttore e il regista seppero fornire, l’uno la giusta dimensione musicale, l’altro un contesto che fece dell’imponente physique du rôle della Norman un punto di forza, per esprimere compiutamente il personaggio e il suo mondo. Il meraviglioso timbro, illuminato dai diversi colori, il vivo senso della parola, sempre innervata da una forte spiritualità e lontana da ogni cedimento virtuosistico, colsero lo specifico della vocalità di Rameau e della tragédie lyrique. Tutto questo si ritrova intatto nella prova de Les Troyens. Si agita nella Cassandre della Norman il grand style, che Berlioz eredita dall’adorato classicismo gluckiano e rivive in chiave romantica.
Così abbiamo un percorso wagneriano lungo il quale la Norman ha incontrato l’Elisabeth del Tannhäuser, la Elsa del Lohengrin, il Liebestod del Tristan und Isolde, la Sieglinde di Die Walküre e la Kundry del Parsifal. E ci ha dato testimonianze preziose della sua voce e della sua arte. La voce si è trovata a suo agio in vocalità e tessiture che sono assimilabili, seppure in maniera diversa, a quella del soprano Falcon. Tra i risultati migliori c’è senza dubbio la Elsa del Lohengrin, dove il soprano americano è riuscito in una di quelle sue interpretazioni originali e, per certi versi fuori dal comune. Ma proprio la particolarità del suo canto, che si realizza all’interno di un fraseggio cauto e sorvegliato, le ha permesso di lasciare un’impronta importante anche nella Kundry del Parsifal, sebbene l’accostamento a questo titolo sia avvenuto al termine del secondo decennio di carriera, quando – inevitabilmente – la voce non aveva più la freschezza degli anni precedenti. Questo itinerario si completa a monte e valle con due interpretazioni non wagneriane, ma di repertorio tedesco. Una, quella a monte, è la Ariadne dell’Ariadne auf Naxos, che affrontata in teatro, per es. al Met, e che è da considerarsi un must. Costituisce uno dei punti più alti della carriera di cantante e di interprete della Norman. Splendore del timbro, gioco di colori, sontuosità di suono, intima adesione alla melodia straussiana, vivo senso della frase trovano piena rispondenza nell’arte della Norman che si identifica con un personaggio a lei congeniale.
Quella a valle è l’Euryanthe che precede, ovviamente, la produzione wagneriana. Il disco del 1974 è assolutamente da ascoltare per due motivi. Permette intanto di sentire una Norman prima maniera con una voce meno densa e di una diversa luminosità rispetto a quello che poi si apprezzerà in teatro e in dischi negli anni successivi. Aggiungo al percorso, anche se si tratta di una deviazione, non essendo assimilabile tout-court, al repertorio tedesco, Il castello di Barbablù di Bartók, inciso sotto la guida di Pierre Boulez quasi vent’anni dopo il capolavoro weberiano. Le condizioni della voce sono cambiate, ma non la capacità della Norman di costruire il personaggio e di entrare in questa musica. L’affronta con una lettura, che ben aderendo alle scelte di Boulez, risulta originale rispetto alle aspettative dettate dalla tradizione. Mi accingo a concludere questo itinerario con una ulteriore forzatura, ma il Compositore è austriaco, Josef Haydn, anche se il titolo in questione fa parte per stile e struttura dell’opera italiana di fine Settecento. Si colloca in quella collana di lavori haydini che Antal Dorati incise per la Philips dagli anni Settanta agli inizi dell’Ottanta. Al ’76 risale La Fedeltà premiata, dove la Norman canta la parte di Rosina, al ’78, invece, Armida, di cui interpreta la parte della protagonista. Le due incisioni vanno ascoltate per assaporare la voce -timbro e colori – di cui la natura e l’arte avevano dotato la Norman e che furono il viatico per quella carriera internazionale che caratterizzò il secondo decennio della sua cattività artistica, quello compreso tra l’Ottanta e il Novanta. C’è poi la felice interpretazione che sa cogliere l’anima dei due personaggi con momenti di vero incanto melodico. La conclusione la lascio, con una deroga che non ha scusanti, alle Nozze di Figaro di Mozart, incise per Decca nel 1971 sotto la direzione di Colin Davis. Qui si ascolterà una cantante freschissima che (mi spiace) non è ancora la Norman, ma un soprano dalla voce fuori dal comune, alla ricerca di un’identità che non potrà essere quella di un soprano puro, ma neppure di un mezzosoprano.
Abbiamo, infine, il percorso della musica da camera, che ha tappe memorabili in alcune opere di Berlioz, Les Nuits d’été, la sinfonia drammatica Roméo et Juliette, La Morte de Cléopatre, nei cicli liederistici di Mahler e di Schönberg, nelle numerose prove straussiane. In questo contesto, più ancora che nell’opera, l’arte della Norman emerge in tutta la sua interezza, nella misura in cui la sua voce si sposa con uno stile finalmente trovato dentro il quale l’artifizio invece di essere annoverato a difetto diventa un pregio e lo diventa anche quando, affrontando il repertorio degli Spirituals e dei Canti natalizi li rende nobili e li eleva o, meglio, li trasporta in una dimensione sublime.
Di Giancarlo Landini